Liuteria a Milano: panoramica
- La vecchia liuteria milanese fino alla fine del XVIII secolo
- La liuteria a Milano: la nuova fioritura del XX secolo
- Liutai milanesi dei giorni nostri
La vecchia liuteria milanese fino alla fine del XVIII secolo
Anche se le origini della liuteria milanese non possono essere paragonate alla grande epoca di Cremona e Brescia - in cui maestri come Andrea e Nicolò Amati, Antonio Stradivari, Guarneri del Gesù, Gasparo da Salò e Giovanni Paolo Maggini crearono niente meno che la definizione del violino valida per secoli e si sviluppò rapidamente una rete altamente produttiva di botteghe di successo sovraregionale - le sue radici vanno sorprendentemente indietro. Anche se nessuna scena liutaria ampiamente differenziata sembra essersi stabilita a Milano tra la fine del XVII e il XVIII secolo, le botteghe della famiglia Grancino divennero il punto di partenza di una tradizione che sarebbe durata per più di 100 anni.
Giovanni Battista Grancino (1637-1709), considerato il fondatore di questa tradizione, potrebbe aver avuto predecessori e maestri in suo padre Andrea e suo nonno Francesco e, questo è certo, lavorò con suo fratello Francesco tra il 1666 e il 1685. Perché le sue opere a cavallo del XVIII secolo rivelino una chiara influenza della scuola di Amati non è chiaro come l'identità di altri due portatori del suo nome, che sono stati a volte identificati nella ricerca come suoi discendenti e allievi; è anche concepibile, tuttavia, che Giovanni Battista «I.» non sia morto fino alla matura età di circa 90 anni e che fossero tutti la stessa persona.
Anche se le sue opere rivelano a volte standard un po' più semplici, per esempio nella scelta del legno - da cui probabilmente si possono trarre conclusioni sulle condizioni di mercato nella Milano del suo tempo - sono proprio gli strumenti più tardi della bottega di Grancino ad essere ancora oggi richiesti come strumenti dal suono forte, e l'alta percentuale di violoncelli nella sua opera giustifica l'alto rango di Grancino nella storia di questa disciplina. 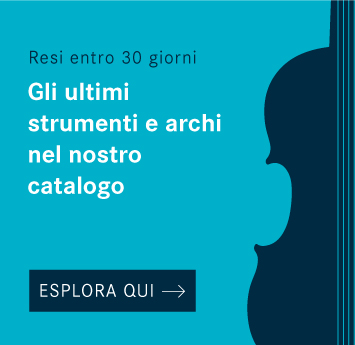
Tra gli allievi di Giovanni Battista Grancino, che comprendono interessanti maestri come Santino Lavazza, Gaetano Pasta e probabilmente anche suo padre Bartolomeo Pasta, Carlo Rotta e Ferdinando Alberti, il rango di legittimo erede della tradizione granciniana spetta probabilmente al grande Carlo Giuseppe Testore (ca. 1660-1716). Il suo lavoro, che come quello del suo maestro è famoso anche per gli eccezionali violoncelli, riflette lo stile di Grancino senza mancare di un forte tocco personale. In esso, il più antico stile milanese continuò a svilupparsi e trovò fedeli conservatori nel figlio di Carlo Giuseppe, Carlo Antonio Testore (1693 - 1765 circa) e suo figlio Giovanni Testore (1724-1765). Nonostante l'eccellente abilità di Carlo Antonio in particolare, alcuni strumenti della sua bottega rivelano tuttavia che egli, come Grancino prima di lui, non fu sempre in grado di lavorare per i clienti più solvibili e fu quindi costretto a fare alcune concessioni, soprattutto estetiche. Queste circostanze sembrano aver pesato ancora di più sul lavoro di suo fratello Paolo Antonio Testore (c. 1690 - c. 1750), che però, come suo figlio Gennaro Testore (c. 1735 - c. 1800), realizzò a sua volta strumenti portanti e dal bel suono con legni inferiori.
Un certo ruolo potrebbe anche essere stato giocato dalla crescente concorrenza derivante dal breve soggiorno di Giovanni Battista Guadagnini a Milano e dall'ascesa della famiglia Landolfi di liutai. È vero che Guadagnini lavorò solo a Milano tra il 1750 e il 58, prima di trasferirsi a Torino passando per Cremona e Parma, dove scriverà la storia degli strumenti musicali insieme al conte Cozio di Salabue. Eppure anche questo breve periodo sembra essere stato sufficiente per avere un effetto duraturo sul mercato locale degli strumenti ad arco, di cui il lavoro di Carlo Ferdinando Landolfi (1710-1784 circa) non è il meno rappresentativo. Il suo lavoro mostra una chiara ispirazione, forse anche formazione, da Guadagnini, e questa indipendenza dalla vecchia tradizione milanese delle famiglie Grancino e Testore ha portato una diversità precedentemente sconosciuta alla liuteria milanese. Carlo Ferdinando Landolfi ebbe un effetto scolastico attraverso suo figlio Pietro Antonio Landolfi (ca. 1730-1795), ma ancor più attraverso i liutai della famiglia Mantegazza, che ebbe un ruolo decisivo nel far sì che la liuteria milanese fiorisse in una certa misura negli ultimi anni del XVIII secolo. Per esempio, fino a cinque altri membri della famiglia probabilmente lavorarono nella bottega dell'allievo di Landolfi, Pietro Giovanni Mantegazza (ca. 1730-1803), le cui esatte relazioni familiari rimangono ancora oggi un mistero irrisolto per i ricercatori. Ciò che è noto, tuttavia, è la base del loro successo economico: la loro ampia collaborazione con il conte Cozio di Salabue, che fece «modernizzare» dai Mantegazza numerosi vecchi violini di maestri italiani. Sembra che abbiano anche completato molti violini del patrimonio di Giovanni Battista Guadagnini, che Cozio aveva acquistato dal suo socio torinese in grande stile.
La liuteria a Milano: la nuova fioritura del XX secolo
Per ragioni sconosciute, le linee della tradizione Grancino-Testore e Guadagnini-Landolfi-Mantegazza non furono continuate nel giovane XIX secolo; anche se la liuteria milanese non si fermò affatto nei decenni successivi, ci volle quasi un secolo prima che le botteghe milanesi fossero di nuovo in grado di sviluppare un appeal sovraregionale.
Il campo fu preparato da atelier più piccoli, alcuni dei quali costruivano buoni strumenti senza avere essi stessi alcun effetto formativo o educativo - e la ditta Monzino, fondata intorno al 1750, che aveva avuto successo a livello internazionale con la costruzione e la vendita di strumenti a pizzico e probabilmente iniziò a rivolgersi alla costruzione di strumenti ad arco sotto la guida di Giacomo Antonio II Monzino (1772-1854).
Come la bottega Monzino, Leandro Bisiach (1864-1946) attirò a Milano verso la fine del XIX secolo eccellenti liutai, tra i quali il suo maestro Riccardo Antoniazzi (1853-1912), che con la sua bottega negli anni 1870-80, come collaboratore di Bisiach dal 1886-1904 e successivamente in casa Monzino, produsse tre periodi di lavoro che, nei loro contesti, erano tutti determinati da alti standard di liuteria. Così, all'inizio del XX secolo, maestri esperti e innovativi si riunirono a Milano come per continuare la tradizione che era stata interrotta 100 anni prima: Oltre ai figli di Leandro Bisiach - Andrea Bisiach (1890-1967), Carlo Bisiach (1892-1968), Giacomo Bisiach (1900-1995) e Leandro II. Bisiach (1904-1982) - Va menzionato Gaetano Sgarabotto (1878-1959) che, con l'appoggio di Antoniazzi e Leandro Bisiach, si formò autodidatta per diventare un maestro di molti premi, così come Luigi Galimberti (1888-1957), Ambrogio Sironi (1902-1939) e Raffaelo Bozzi (1905-1981).
Accanto a Bisiach, Celeste Farotti (1864-1928) si stabilì a Milano a partire dal 1900, un liutaio altrettanto talentuoso che proveniva dalla stessa zona di Leandro Bisiach e si fece rapidamente un nome con riparazioni impegnative. Farotti divenne un vero concorrente di Bisiach, che era solo due mesi più giovane, quando, incoraggiato dai suoi successi, si rivolse a nuove costruzioni e stabilì uno stile che, con il suo orientamento verso Giovanni Francesco Pressenda e Giuseppe Rocca, contrastava in modo interessante con l'emergente nuova scuola milanese. Fu supportato da Alfred Lanini (1891-1956), il cui apprendistato con Antoniazzi fu interrotto bruscamente dalla morte prematura del maestro e che, dopo il suo periodo con Farotti, lavorò nella sua casa californiana come maestro estremamente produttivo e sperimentale, e da suo nipote Celestino Farotto (1905-1988), che lavorò anche per Bisiach dopo la seconda guerra mondiale e ricevette numerosi premi per il suo ampio lavoro.
Liutai milanesi dei giorni nostri
Anche grazie alla Civica Scuola di Liuteria di Milano, la scuola di liuteria fondata nel 1978, Milano rivendica oggi un posto fisso nel mondo della liuteria. Ma anche al di fuori dei laboratori didattici, si è affermata una scena liutaria gestibile ma vivace e interessante, che attinge agli impulsi della nuova liuteria milanese.
L'esempio più evidente di questa continuità è senza dubbio il liutaio Nicola Enrico Antonio Monzino (1970-), con il quale la tradizione di questa rinomata azienda familiare ha già superato di gran lunga il suo 250° anno. Nello spirito di suo nonno Antonio VI. Carlo Monzino (1909-2004), l'erede di questa lunga linea di imprenditori e liutai di successo, vede il suo laboratorio come uno studio di eccellenza di liuteria classica - un nuovo «Laboratorio Monzino».
Strettamente legato alle istituzioni della vita musicale milanese è Delfi Merlo (1961-), che ha iniziato la sua carriera nel 1977 come apprendista da Monzino, e pochi anni dopo ha completato un apprendistato di liuteria classica alla Scuola di Liuteria di Cremona. Dopo aver aperto il suo laboratorio, ha ricevuto commissioni di restauro dal Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco di Milano e ha lavorato per il Conservatorio e il famoso Teatro alla Scala. Dall'inizio degli anni '90, ha anche guadagnato una buona reputazione internazionale con strumenti di nuova costruzione.
Tra i diplomati più recenti della Scuola di Liuteria di Milano c'è Lorenzo Rossi, che ha scoperto l'amore per la liuteria mentre studiava fisica e da quando si è laureato ha seguito numerosi corsi con maestri internazionali come Carlos Arcieri e Guy Rabut, anche nelle tecniche di restauro più all'avanguardia. Ha vinto diversi premi per i suoi strumenti in mostre rinomate come il Concorso Triennale Internazionale die Liuteria Antonio Stradivari.
Altri accenti non meno interessanti sono posti da Stefano Bertoli, che ha studiato anch'egli alla scuola milanese e che da allora ha coltivato una stretta collaborazione con Carlo Chiesa - un altro diplomato della stessa scuola, che condivide con Bertoli un particolare interesse per le tecniche classiche e artigianali e che lo ha ispirato ad approfondire l'arte della scultura del legno.
<p><strong>Contenuti:</strong></p><ul><li><a href="#vecchia-liuteria-milanese">La vecchia liuteria milanese fino alla fine del XVIII secolo</a></li><li><a href="#liuteria-milano">La liuteria a Milano: la nuova fioritura del XX secolo</a></li><li><a href="#liutai-milanesi-oggi">Liutai milanesi dei giorni nostri</a></li></ul>
<h2 id="vecchia-liuteria-milanese">La vecchia liuteria milanese fino alla fine del XVIII secolo</h2><p>Anche se le origini della liuteria milanese non possono essere paragonate alla grande epoca di Cremona e Brescia - in cui maestri come Andrea e Nicolò Amati, Antonio Stradivari, Guarneri del Gesù, Gasparo da Salò e Giovanni Paolo Maggini crearono niente meno che la definizione del violino valida per secoli e si sviluppò rapidamente una rete altamente produttiva di botteghe di successo sovraregionale - le sue radici vanno sorprendentemente indietro. Anche se nessuna scena liutaria ampiamente differenziata sembra essersi stabilita a Milano tra la fine del XVII e il XVIII secolo, le botteghe della famiglia Grancino divennero il punto di partenza di una tradizione che sarebbe durata per più di 100 anni.</p>
<p>Giovanni Battista Grancino (1637-1709), considerato il fondatore di questa tradizione, potrebbe aver avuto predecessori e maestri in suo padre Andrea e suo nonno Francesco e, questo è certo, lavorò con suo fratello Francesco tra il 1666 e il 1685. Perché le sue opere a cavallo del XVIII secolo rivelino una chiara influenza della scuola di Amati non è chiaro come l'identità di altri due portatori del suo nome, che sono stati a volte identificati nella ricerca come suoi discendenti e allievi; è anche concepibile, tuttavia, che Giovanni Battista «I.» non sia morto fino alla matura età di circa 90 anni e che fossero tutti la stessa persona.</p>
<p>Anche se le sue opere rivelano a volte standard un po' più semplici, per esempio nella scelta del legno - da cui probabilmente si possono trarre conclusioni sulle condizioni di mercato nella Milano del suo tempo - sono proprio gli strumenti più tardi della bottega di Grancino ad essere ancora oggi richiesti come strumenti dal suono forte, e l'alta percentuale di violoncelli nella sua opera giustifica l'alto rango di Grancino nella storia di questa disciplina.</p>
<p>Tra gli allievi di Giovanni Battista Grancino, che comprendono interessanti maestri come Santino Lavazza, Gaetano Pasta e probabilmente anche suo padre Bartolomeo Pasta, Carlo Rotta e Ferdinando Alberti, il rango di legittimo erede della tradizione granciniana spetta probabilmente al grande Carlo Giuseppe Testore (ca. 1660-1716). Il suo lavoro, che come quello del suo maestro è famoso anche per gli eccezionali violoncelli, riflette lo stile di Grancino senza mancare di un forte tocco personale. In esso, il più antico stile milanese continuò a svilupparsi e trovò fedeli conservatori nel figlio di Carlo Giuseppe, Carlo Antonio Testore (1693 - 1765 circa) e suo figlio Giovanni Testore (1724-1765). Nonostante l'eccellente abilità di Carlo Antonio in particolare, alcuni strumenti della sua bottega rivelano tuttavia che egli, come Grancino prima di lui, non fu sempre in grado di lavorare per i clienti più solvibili e fu quindi costretto a fare alcune concessioni, soprattutto estetiche. Queste circostanze sembrano aver pesato ancora di più sul lavoro di suo fratello Paolo Antonio Testore (c. 1690 - c. 1750), che però, come suo figlio Gennaro Testore (c. 1735 - c. 1800), realizzò a sua volta strumenti portanti e dal bel suono con legni inferiori.</p>
<p>Un certo ruolo potrebbe anche essere stato giocato dalla crescente concorrenza derivante dal breve soggiorno di Giovanni Battista Guadagnini a Milano e dall'ascesa della famiglia Landolfi di liutai. È vero che Guadagnini lavorò solo a Milano tra il 1750 e il 58, prima di trasferirsi a Torino passando per Cremona e Parma, dove scriverà la storia degli strumenti musicali insieme al conte Cozio di Salabue. Eppure anche questo breve periodo sembra essere stato sufficiente per avere un effetto duraturo sul mercato locale degli strumenti ad arco, di cui il lavoro di Carlo Ferdinando Landolfi (1710-1784 circa) non è il meno rappresentativo. Il suo lavoro mostra una chiara ispirazione, forse anche formazione, da Guadagnini, e questa indipendenza dalla vecchia tradizione milanese delle famiglie Grancino e Testore ha portato una diversità precedentemente sconosciuta alla liuteria milanese. Carlo Ferdinando Landolfi ebbe un effetto scolastico attraverso suo figlio Pietro Antonio Landolfi (ca. 1730-1795), ma ancor più attraverso i liutai della famiglia Mantegazza, che ebbe un ruolo decisivo nel far sì che la liuteria milanese fiorisse in una certa misura negli ultimi anni del XVIII secolo. Per esempio, fino a cinque altri membri della famiglia probabilmente lavorarono nella bottega dell'allievo di Landolfi, Pietro Giovanni Mantegazza (ca. 1730-1803), le cui esatte relazioni familiari rimangono ancora oggi un mistero irrisolto per i ricercatori. Ciò che è noto, tuttavia, è la base del loro successo economico: la loro ampia collaborazione con il conte Cozio di Salabue, che fece «modernizzare» dai Mantegazza numerosi vecchi violini di maestri italiani. Sembra che abbiano anche completato molti violini del patrimonio di Giovanni Battista Guadagnini, che Cozio aveva acquistato dal suo socio torinese in grande stile.</p>
<h2 id="liuteria-milano">La liuteria a Milano: la nuova fioritura del XX secolo</h2><p>Per ragioni sconosciute, le linee della tradizione Grancino-Testore e Guadagnini-Landolfi-Mantegazza non furono continuate nel giovane XIX secolo; anche se la liuteria milanese non si fermò affatto nei decenni successivi, ci volle quasi un secolo prima che le botteghe milanesi fossero di nuovo in grado di sviluppare un appeal sovraregionale.</p>
<p>Il campo fu preparato da atelier più piccoli, alcuni dei quali costruivano buoni strumenti senza avere essi stessi alcun effetto formativo o educativo - e la ditta Monzino, fondata intorno al 1750, che aveva avuto successo a livello internazionale con la costruzione e la vendita di strumenti a pizzico e probabilmente iniziò a rivolgersi alla costruzione di strumenti ad arco sotto la guida di Giacomo Antonio II Monzino (1772-1854).</p>
<p>Come la bottega Monzino, Leandro Bisiach (1864-1946) attirò a Milano verso la fine del XIX secolo eccellenti liutai, tra i quali il suo maestro Riccardo Antoniazzi (1853-1912), che con la sua bottega negli anni 1870-80, come collaboratore di Bisiach dal 1886-1904 e successivamente in casa Monzino, produsse tre periodi di lavoro che, nei loro contesti, erano tutti determinati da alti standard di liuteria. Così, all'inizio del XX secolo, maestri esperti e innovativi si riunirono a Milano come per continuare la tradizione che era stata interrotta 100 anni prima: Oltre ai figli di Leandro Bisiach - Andrea Bisiach (1890-1967), Carlo Bisiach (1892-1968), Giacomo Bisiach (1900-1995) e Leandro II. Bisiach (1904-1982) - Va menzionato Gaetano Sgarabotto (1878-1959) che, con l'appoggio di Antoniazzi e Leandro Bisiach, si formò autodidatta per diventare un maestro di molti premi, così come Luigi Galimberti (1888-1957), Ambrogio Sironi (1902-1939) e Raffaelo Bozzi (1905-1981).</p>
<p>Accanto a Bisiach, Celeste Farotti (1864-1928) si stabilì a Milano a partire dal 1900, un liutaio altrettanto talentuoso che proveniva dalla stessa zona di Leandro Bisiach e si fece rapidamente un nome con riparazioni impegnative. Farotti divenne un vero concorrente di Bisiach, che era solo due mesi più giovane, quando, incoraggiato dai suoi successi, si rivolse a nuove costruzioni e stabilì uno stile che, con il suo orientamento verso Giovanni Francesco Pressenda e Giuseppe Rocca, contrastava in modo interessante con l'emergente nuova scuola milanese. Fu supportato da Alfred Lanini (1891-1956), il cui apprendistato con Antoniazzi fu interrotto bruscamente dalla morte prematura del maestro e che, dopo il suo periodo con Farotti, lavorò nella sua casa californiana come maestro estremamente produttivo e sperimentale, e da suo nipote Celestino Farotto (1905-1988), che lavorò anche per Bisiach dopo la seconda guerra mondiale e ricevette numerosi premi per il suo ampio lavoro.</p>
<h2 id="liutai-milanesi-oggi">Liutai milanesi dei giorni nostri</h2><p>Anche grazie alla Civica Scuola di Liuteria di Milano, la scuola di liuteria fondata nel 1978, Milano rivendica oggi un posto fisso nel mondo della liuteria. Ma anche al di fuori dei laboratori didattici, si è affermata una scena liutaria gestibile ma vivace e interessante, che attinge agli impulsi della nuova liuteria milanese.</p>
<p>L'esempio più evidente di questa continuità è senza dubbio il liutaio Nicola Enrico Antonio Monzino (1970-), con il quale la tradizione di questa rinomata azienda familiare ha già superato di gran lunga il suo 250° anno. Nello spirito di suo nonno Antonio VI. Carlo Monzino (1909-2004), l'erede di questa lunga linea di imprenditori e liutai di successo, vede il suo laboratorio come uno studio di eccellenza di liuteria classica - un nuovo «Laboratorio Monzino».</p>
<p>Strettamente legato alle istituzioni della vita musicale milanese è Delfi Merlo (1961-), che ha iniziato la sua carriera nel 1977 come apprendista da Monzino, e pochi anni dopo ha completato un apprendistato di liuteria classica alla Scuola di Liuteria di Cremona. Dopo aver aperto il suo laboratorio, ha ricevuto commissioni di restauro dal Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco di Milano e ha lavorato per il Conservatorio e il famoso Teatro alla Scala. Dall'inizio degli anni '90, ha anche guadagnato una buona reputazione internazionale con strumenti di nuova costruzione.</p>
<p>Tra i diplomati più recenti della Scuola di Liuteria di Milano c'è Lorenzo Rossi, che ha scoperto l'amore per la liuteria mentre studiava fisica e da quando si è laureato ha seguito numerosi corsi con maestri internazionali come Carlos Arcieri e Guy Rabut, anche nelle tecniche di restauro più all'avanguardia. Ha vinto diversi premi per i suoi strumenti in mostre rinomate come il Concorso Triennale Internazionale die Liuteria Antonio Stradivari.</p>
<p>Altri accenti non meno interessanti sono posti da Stefano Bertoli, che ha studiato anch'egli alla scuola milanese e che da allora ha coltivato una stretta collaborazione con Carlo Chiesa - un altro diplomato della stessa scuola, che condivide con Bertoli un particolare interesse per le tecniche classiche e artigianali e che lo ha ispirato ad approfondire l'arte della scultura del legno.</p>
Originally published by Corilon violins.





