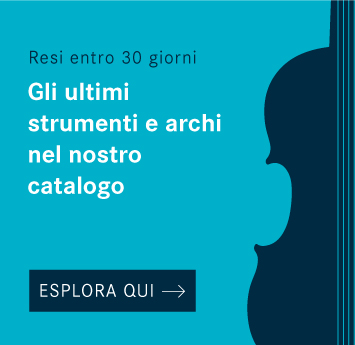La Ciaccona della Partita n. 2 in re minore di Johann Sebastian Bach è considerata una delle composizioni più impressionanti della letteratura violinistica. Molti interpreti e ricercatori la considerano più di un semplice capolavoro tecnico e interpretano il brano come un'espressione musicale di dolore personale. Forse scritta in memoria della prima moglie defunta di Bach, la Ciaccona unisce profondità emotiva e rigore compositivo. Il suo effetto si basa su un'intensità tranquilla che risuona ancora oggi e la sua decifrazione pone importanti interrogativi a musicisti e musicologi.
Panoramica
1. La Ciaccona – struttura, simbolismo numerico e intertestualità
2. contesto della ciaccona nella vita e nelle opere di J. S. Bach
3. Arrangiamenti e trascrizioni della ciaccona
4. Interpreti importanti della ciaccona
5. Spartiti: Importanti edizioni della Ciaccona
6. Il violino giusto per la Ciaccona – la scelta dello strumento nel contesto storico e moderno
1. La ciaccona – struttura, simbolismo numerico e intertestualità
La struttura della Ciaccona di Bach
La Ciaccona di Bach è un'opera monumentale di 256 battute, più dei quattro movimenti precedenti della Partita n. 2 in re minore (BWV 1004) messi insieme, che costituiscono il suo contesto immediato. Si basa sulla forma dell'Ostinato, in cui un basso ricorrente costituisce la base. Bach si rifà alla tradizione italiana, in cui il tema è spesso figurativo e difficile da riconoscere. Nella Ciaccona, il motivo del basso alterna un lamento basso (d-c-b-a) e un passus duriusculus.
Simbolismo numerico e riferimenti intertestuali nella Ciaccona di Johann Sebastian Bach
La complessità della ciaccona si riflette in una pletora di analisi scientifiche, tra le quali le strutture da interpretare sono spesso controverse. Ad esempio, diverse analisi ipotizzano una struttura in 64 variazioni di quattro battute, mentre altre suddividono la ciaccona in 34 variazioni, in cui le prime quattro battute ricorrono 8 volte e tutte le otto battute altre 26 volte. La divisione in tre parti in una prima sezione minore con 33 variazioni, una sezione centrale maggiore con 19 e una sezione finale minore con 12 variazioni porta a un aumento drammatico attraverso la riduzione delle variazioni per sezione: la musica diventa più intensa, più densa, le cadenze iniziano prima. Inoltre, i passaggi diatonici e cromatici, le tonalità minori e maggiori, le pause accordali e le scale contrastano tra loro. La polifonia, spesso solo accennata, è suggerita da un'abile conduzione della voce, come è presente in forma simile anche nelle famose suite per violoncello di Bach (vedi sotto, capitolo 2).
Sulla base di queste osservazioni strutturali, i musicologi hanno esplorato l'architettura tonale della ciaccona non solo dal punto di vista musicale, ma anche simbolico numerico; molti autori interpretano la divisione in tre sezioni (minore-maggiore-minore) come una narrazione spirituale o biografica. Heinrich Poos, ad esempio, vede nel numero 4 un'allegoria dei quattro elementi o delle quattro stagioni (musica mundana), delle quattro età (musica humana) e delle quattro corde del violino (musica instrumentalis). Altri studiosi analizzano le strutture simmetriche e ipotizzano che il numero 30 – il numero di variazioni prima e dopo la sezione maggiore – sia un calcolo compositivo deliberato che si ritrova anche in altre opere come le Variazioni Goldberg.
Helga Thoene si spinge particolarmente in là nella sua analisi. Nel suo libro „Ciaccona – Tanz oder Tombeau?“ sostiene che Bach abbia composto con la Ciaccona un monumento funebre per la moglie defunta. Identifica corali nascosti, basati sulla conversione delle note in numeri (gematria), e scopre riferimenti all'anno ecclesiastico nella composizione. sostiene una tesi simile, utilizzando un alfabeto numerico per identificare i nomi della famiglia Bach nel testo musicale. Critici come Martin Geck considerano queste tesi speculative, ma sottolineano che il simbolismo numerico ha avuto un ruolo importante nel periodo barocco. Geck mette inoltre in guardia dal ricorrere alle edizioni a stampa, poiché solo gli autografi rappresentano autenticamente il processo compositivo.
2. Contesto della Ciaccona nella vita e nell'opera di J. S. Bach
La Ciaccona è il movimento finale della Partita n. 2 in re minore (BWV 1004), una delle sei opere del ciclo „Sei Solo. a Violino senza Basso accompagnato“ (BWV 1001–1006). Secondo la copia corretta, questo ciclo fu composto a Köthen nel 1720, mentre gli inizi potrebbero risalire al periodo di Weimar (1708–1717). Bach trovò a Köthen le condizioni ideali: Il principe Leopold von Anhalt-Köallora era estremamente appassionato di musica, l'orchestra di corte aveva un organico eccellente e la musica strumentale era particolarmente favorita.
La Ciaccona di Bach come opera solistica polifonica
Il „Sei Solo“ e le suite per violoncello (BWV 1007–1012) dimostrano la profonda familiarità di Bach con la tecnica esecutiva dei rispettivi strumenti. Nonostante la rinuncia al basso continuo, riesce a creare una densa polifonia e armonie complesse. Melodie accordali solistiche, monofonia pura e polifonia suggestiva si combinano in modo unico.
La Ciaccona occupa qui una posizione speciale, sia in termini di virtuosismo che di espressione. Il suo rigore formale e la sua profondità emotiva la rendono un'opera chiave nell'opera di Bach e un punto culminante della letteratura per violino solo.
3. Arrangiamenti e trascrizioni della Ciaccona
Arrangiamenti della Ciaccona di Johann Sebastian Bach nel XIX secolo
La Ciaccona di Johann Sebastian Bach ha subito numerosi arrangiamenti e trascrizioni nel corso del tempo. Già a metà del XIX secolo, i musicisti iniziarono ad adattare l'opera per altri strumenti. Esponenti come Felix Mendelssohn Bartholdy e Robert Schumann ritenevano incomprensibile che Bach avesse scritto questa partita senza alcun accompagnamento. Mendelssohn pubblicò un accompagnamento per pianoforte nel 1847, Schumann lo seguì nel 1853 e l'arrangiamento del violinista August Wilhelmj del 1885, che aggiunse anche una versione orchestrale, è particolarmente impressionante.
Le trascrizioni per pianoforte, iniziate negli anni Cinquanta dell'Ottocento, raggiungono il loro apice nel 1893 con l'arrangiamento di Ferruccio Busoni. Quest'ultimo è talmente originale da essere spesso considerato un'opera a sé stante.
Profondità religiosa: la versione di Helga Thoene della Ciaccona di Johann Sebastian Bach
C'è anche un'interpretazione musicale dell'analisi di Helga Thoene discussa nel capitolo 1: la Thoene ha fornito all'opera le citazioni corali da lei individuate, che a suo avviso si snodano come un cantus firmus musicale. Insieme al violinista Christoph Poppen e all'Hillard-Ensemble, ha registrato un CD in cui il corale e i movimenti della partita si intrecciano. Questa registrazione rappresenta una forma particolare di ricezione che sottolinea la profondità religiosa ed emotiva dell'opera.
4. Importanti interpreti della Ciaccona
La Ciaccona è stata e continua ad essere interpretata dai più importanti violinisti della storia della musica. È disponibile nella sua forma originale per violino solo nelle registrazioni di Jascha Heifetz, Yehudi Menuhin e Gidon Kremer. L'interpretazione di Heifetz del 1952 si basa sulla partitura del suo insegnante Leopold Auer, il cui stile romantico di esecuzione – che include portamento e spiccato – non è privo di controversie.
Joseph Szigeti, un „nipote“ di Joseph Joachim, registrò nel 1956 una versione che combinava la prospettiva storicamente informata di Joachim con un'interpretazione romantica. Arthur Grumiaux ha portato una chiarezza polifonica nella sua registrazione del 1961, mentre Christian Tetzlaff ha combinato uno stile esecutivo di ispirazione barocca con una tecnica moderna nel 1995 - con un tempo veloce, vibrato e ornamenti ridotti..
La Ciaccona di J. S. Bach nella prassi esecutiva storica
Interpretazioni storicamente informate su violini barocchi, ad esempio di Sigiswald Kuijken (1981) o Rachel Podger (1997/1999), gettano nuova luce sull'opera. Con un'esecuzione particolarmente insolita, Joshua Bell si è assicurato un posto nella storia dell'interpretazione della Ciaccona, suonandola come musicista di strada in una stazione della metropolitana di Washington nel 2008.
Yehudi Menuhin considerava la Ciaccona l'opera più importante per violino solo. Il pianista Hélène Grimaud la descrive come una „danza della vita e della morte“ – un'opera dall'architettura simile a una cattedrale, le cui variazioni sono come luce colorata attraverso le vetrate colorate.
5 Note: Importanti edizioni della Ciaccona
La Ciaccona è stata pubblicata in numerose edizioni musicali, molto diverse tra loro per impostazione editoriale e orientamento interpretativo. conformate storicamente, hanno posto l'accento su una riproduzione il più possibile originale della fonte. Alcune edizioni integrano diteggiature, segni di battuta e indicazioni dinamiche, mentre altre offrono solo il testo musicale puro. Per le edizioni odierne, le edizioni riconosciute del testo originale costituiscono una base indispensabile; a prescindere da ciò, la storia dell'arrangiamento e dell'interpretazione con le realizzazioni storiche di importanti musicisti sono fonti a sé stanti, che inevitabilmente influenzano ogni nuovo esame della Ciaccona di Bach e possono essere rese fruttuose per gli approcci artistici.
.
6. Il violino giusto per la ciaccona – Scelta dello strumento in un contesto storico e moderno
Quale violino è più adatto all'interpretazione della Ciaccona di Bach?
Questa domanda riguarda sia gli interpreti della prassi esecutiva storicamente informata sia i violinisti moderni. All'epoca di Bach erano diffusi strumenti della tradizione della famiglia Amati, di Jakob Stainer e dei primi Stradivari. I violini di Stainer, in particolare, godevano di una reputazione eccezionale ed esemplare nel mondo di lingua tedesca grazie alla loro risonanza eccezionalmente elevata nel confronto storico e al loro suono caldo e scuro.
Un aspetto importante e fondamentale nella questione del violino giusto per la ciaccona è la differenza tra i violini moderni e i violini barocchi, che erano la norma all'epoca di Bach: Con il loro manico più corto, una stanghetta più leggera, corde di budello e altre differenze strutturali, offrono un suono significativamente diverso rispetto ai moderni violini da concerto sviluppatisi sulla scia di Stradivari. Il tono più morbido e intimo degli strumenti barocchi ha prevalso in molte interpretazioni contemporanee e sembra essere particolarmente adatto alla struttura in filigrana della ciaccona, e non solo per ragioni storiche. In generale, va notato che i violini con una caratteristica sonora troppo morbida o dolce sono meno adatti alla Ciaccona di Bach, poiché di solito riflettono solo in modo inadeguato lo spettro tonale previsto dalla composizione.
Interpretare la Ciaccona di Bach con i violini moderni
Tuttavia, per quanto i violini barocchi siano importanti per opere come la Ciaccona, le registrazioni con violini moderni dimostrano che anche su di essi sono possibili interpretazioni eccellenti, e non solo quando lo stile esecutivo si basa su tecniche barocche. Quando si ha a che fare con il vibrato, la tecnica dell'arco e l'articolazione, si crea una tensione tra l'autenticità storica e l'assertività tonale. Chi suona Bach oggi si trova di fronte a una scelta: il tentativo di ricreare il mondo sonoro originale o l'obiettivo di far rivivere la musica di Bach con mezzi contemporanei. Entrambe le strade hanno la loro giustificazione ed entrambe conducono al cuore della ciaccona.